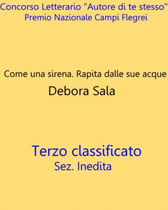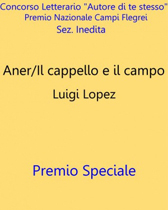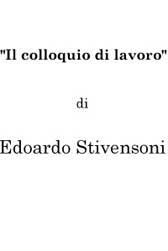“Non so quando ho ceduto…” di Natalia Bondarenko
Non so quando ho ceduto.
Non riesco a cogliere il momento preciso in cui la mente non è riuscita più a gestire questa situazione.
Aspettando l’imbarco del mio volo nell’aeroporto completamente e stranamente vuoto, mi ritenevo quasi fortunata nel sentir parlare quella donna, sessantenne o più o meno di quell’età, vestita con una tuta sportiva con vistoso marchio Adidas. Aveva numerose piccole borse attorno e doveva, dopo Kiev, andare nella stessa mia destinazione, nella città della mia infanzia e adolescenza, nella città della quale dopo 20 anni di assenza non ricordavo granché tranne…
“Mi vengono a prendere i miei nipoti … con la macchina…” – diceva, distraendomi, e il mio cuore saltava per questa inattesa ‘fortuna’.
Lei si preoccupava del ritardo della partenza. Il suo era il secondo volo nella sua vita. Il ritorno. E in mezzo alle sue agitazioni sulla sedia, in cerca di qualche spiegazione che non arrivava, come la mancanza del personale dell’aeroporto, cercavo di spillare da lei qualche informazione sul posto dove dovevamo andare, mettendo in mezzo alle parole il motivo del mio viaggio, spiegando che è morta mia mamma.
Lei mi guardò quasi con spavento.
“Non è morta adesso. È morta un mese fa. Anche di più. Mi è arrivata la lettera troppo tardi. Non hanno pensato di mandarmi il telegramma…” – sembrava una balla, ma era la pura verità.
Dopo cercai di cambiare subito il discorso, parlando del viaggio.
Disse che non conveniva più prendere i treni di una volta, che le cose erano cambiate completamente e gli autobus erano stati sostituiti con pulmini o taxi. Gli ultimi erano molto cari e pericolosi. Parlava di tutto e di niente. Di 260 kilometri da fare purtroppo di sera e della cosiddetta trassa, una specie di autostrada ucraina, che nel frattempo è molto migliorata, senza precisare con che epoca faceva questo paragone; che in quattro ore massimo saremo a casa e che loro, i nipoti, mi porteranno quasi fin sotto casa mia…. Perché alla fine abbiamo scoperto che eravamo quasi vicini di casa.
Non so quando ho ceduto.
Il viaggio sembrava una vera passeggiata nel cielo: noi due, sole in un piccolo aereo di linea slovena, con la hostess bionda dal viso da Barbi che si rifiutava di parlare italiano e continuava a chiedere tutto in sloveno o inglese. Ma alla fine abbiamo comunicato senza nessun problema in russo.
In quelle due ore ho riso molto, perché la donna conosceva molte barzellette e ogni tanto si ricordava di mettere in bocca piccoli paninetti con il salame e approfittava del vino rosso offerto dalla compagnia di volo. E anche dopo, in macchina, si sentiva in dovere di raccontare tutto: parlava di come era cambiata la città negli ultimi vent’anni, cosa esisteva ancora e cosa non poteva più esistere per forza, del monumento a Lenin che sta sempre allo solito posto con la sua mano protesa verso Kiev e di come qualcuno voleva girarlo nella direzione dell’Europa, di chi è stato ucciso perché si è arricchito troppo in fretta e di chi avvelenato perché magari non voleva dividere le sue ricchezze con qualcuno, e che la milizia non sa neanche dove mettere le mani.
Quella sera, saltando sui buchi della trassa più ‘curata’ dell’ Ucraina (si è rivelata una semplice strada con due corsie a doppia circolazione) e stretta da tutti e due i lati, sul sedile posteriore di una macchina coreana in mezzo a due ragazzi, nipoti della donna, con forte nauseante odore da mancanza di semplice igiene personale, osservavo la nebbia e la mancanza di qualsiasi segnale o illuminazione stradale. A parte le luci di qualche macchina che si incrociava, il buio era totale. Le quattro ore promesse si erano trasformate in sei ore abbondanti e nonostante i muscoli del mio corpo fossero paralizzati dalle scomodità di questo viaggio che si allungava all’infinito – nel profondo del mio cuore mi sentivo una persona felice.
Non so quando ho ceduto. Davvero.
Attraversavo tutto l’enorme cortile che portava verso il portone di casa mia con il fiato quasi sospeso, guardando attorno la trascuratezza totale e mi domandavo se è sempre stato così o sono io che non sono più abituata. E salendo le scale piene di sporcizia, di vetri rotti e fili elettrici e telefonici appesi agli angoli del soffitto e ingarbugliati fra di loro, sorridevo stupidamente perché mi accorgevo di non ricordare più il piano.
Dentro, la casa puzzava di colore fresco. Dalla lucentezza dei pavimenti si capiva che erano stati appena pitturati, ma i buchi fra le tavole di legno formati col tempo avevano bisogno di stucco. La donna, Antonina, con la quale mi era capitato di parlare solo una volta nella mia vita e che aveva badato a mia madre fino alla morte, come a comando, appena mi vide si mise a piangere.
“No!!” – la supplicai. Mi sentivo in imbarazzo e pensavo che dovrei piangere almeno per proforma, ma non mi veniva neanche una lacrima.
Feci i primi passi nella saletta osservando i mobili e gli oggetti che erano rimasti gli stessi come li avevo lasciati venti anni prima: le stesse sculturine, i piatti smaltati e i piccoli vasetti di vecchia ceramica galiziana tenuti in vista in vetrina. Ogni centimetro del muro verdino abbellito con i quadri di mia madre. E l’odore. Sempre lo stesso. Solo mescolato con l’odore nauseabondo dei pavimenti pitturati.
“Tu dormirai nel mio letto… “ – la donna era molto servizievole – “ e qua ci sono tutte le cose che tua mamma ti ha lasciato… devi vedere… e leggere…”.
E mi mostrava una montagna di vecchie cartelle per terra accanto a un letto matrimoniale messo in un angolo per mancanza di spazio.
Dopo aver mangiato velocemente un piatto con patate lesse e carne inscatolata, immaginando pennette al ragù, con la scusa di essere molto stanca e voler dormire, mi isolai nella stanza cercando di evitare l’imbarazzo di parlare con una sconosciuta che continuava a ripetere con le stesse parole per l’ennesima volta in mezz’ora come era morta mia mamma. Avrò ancora tempo… pensai … Per oggi è già troppo.
Non so dire con precisione quando ho ceduto.
Ma quella notte non riuscii a dormire.
Non riuscivo proprio a chiudere gli occhi. La stanza che una volta era mia ed era piena di libri, le enciclopedie e i cataloghi d’arte, messi contro il muro sulle librerie alte fino al soffitto e il pianoforte Petroff, il mio primo baby-sitter ed amico e che era sparito chi sa dove, erano stati sostituiti da tappeti di scarsa qualità messi solo per abbellimento e, come sempre diceva mia madre, per la voglia di apparire ricchi. Per lei la ricchezza aveva tutt’altro valore: la conoscenza e la sapienza in tutti i suoi aspetti, la ricchezza di spirito era preferita ai cristalli, ai tappeti e agli ori.
Quella notte non dormivo. Respiravo pesantemente l’aria calda del riscaldamento che andava a tutto forza anche di notte, guardando la riga della luce che tagliava il muro in due e mi chiedevo che sono venuta a fare qua… che …. ormai….è morta.
Nel mezzo della notte un crampo allo stomaco mi avvisò che quello che avevo mangiato non era più adatto a me. Corsi in bagno e scoprii che la porta non si chiudeva: gli strati di colore messi negli anni uno sopra l’altro avevano rovinato il suo funzionamento. Non avevo scelta. Me ne fregai pensando che Antonina era abituata al peggio con mia madre. Ma per lavarmi le mani dovetti andare in cucina: il rubinetto del bagno era completamente stuccato con il cemento. La mattina dopo lei mi spiegò che non riuscendo a pagare l’idraulico, avevano risolto il problema della perdita d’acqua coprendo completamente il rubinetto con il cemento. Ma anche per chiudere quello della cucina ho dovuto scoprire un trucco: dovevo schiacciarlo verso il muro per bloccare uscita dell’acqua perché non so come mai il rubinetto si apriva girando da tutte e due le parti.
Non so quando ho ceduto.
Magari quando ho visto la tomba con i fiori di cartapesta e la scritta che diceva che erano da parte mia. Ma neanche allora ho pianto. Decidevamo che croce mettere, di che grandezza e di che colore. Mia madre credeva di essere una credente e voleva ad ogni costo la croce antica. A sei punte.
Più tardi, a casa, Antonina mi disse che al cimitero ero bianca come la neve. Ed io replicai che non riesco a piangere davanti ad altri, per non specificare che per me lei era una persona assolutamente estranea. Ma lei ripeteva che mi voleva come parte della sua famiglia perché, ormai, sapeva molte cose del mio passato. Come quella volta quando arrivò una mia lettera dove io pregavo mia mamma di non giudicarmi e di non accusarmi di niente, perché molti miei problemi comportamentali erano legati (come diceva lo psicologo al quale avevo dovuto rivolgermi per forza) al passato.
Quando avevo undici o dodici anni e per mesi e mesi, approfittando delle assenze di mia madre per lavoro, facevo parte del gioco inventato da suo marito, mio patrigno. Il quale mi obbligava a tirare giù le mutandine e metteva la sua testa con i capelli ricci e brizzolati su mio pube ancora privo dei peli, provocandomi solletico e fastidio. Era un gioco che non comprendevo: lui stava così per ore usando il mio corpo come semplice cuscino per guardare la televisione.
Antonina disse che non voleva leggere quella lettera cosi privata, ma mia madre aveva insistito. Dopo, però, lei per tutta la sera aveva voluto rimanere da sola. “Si vergognava per lui” – concluse Antonina con sicurezza. Non mi ha creduto pensai, ricordando la sua lettera arrivata dopo un po’, senza nessun accenno al mio discorso così importante e vitale.
“Non mi hai creduto!” – guardando la sua tomba, non piangevo. Soltanto, come diceva Antonina, ero bianca come la neve.
Non so quando di preciso ho ceduto.
Questa donna che cercava di possedere anche me, come aveva posseduto casa mia e il tutto resto per aver guardato lentamente morire mia madre, continuava a ripetere:
“Non voleva farti soffrire, non voleva che venissi neanche ai funerali…”
E poi, mentre mi raccontava gli ultimi anni della malattia di mia madre quasi minuto per minuto, mi rendevo conto che se solo avessi saputo la metà di tutto questo, avrei potuto magari finalmente svolgere il mio ruolo di figlia come sempre desideravo, mandando almeno qualche medicina utile, visto che l’ultimo scandalo delle medicine “false” aveva demolito completamente la fiducia degli ucraini nella loro struttura sanitaria.
Ogni mattina trovavo la finestra della stanza dove era morta mia madre spalancata: Antonina diceva che se non lo faceva – si sarebbe sentito ancora l’odore della necrosi della pelle. La chiesi di non farlo più finché ero lì. Volevo sentire l’ultimo odore di mia madre.
Non so … quando…
Camminando per le strade della mia infanzia e non riconoscendole più, Antonina, agganciata al mio braccio, cercava di deviare il mio percorso nelle direzioni opposte:
“Dopo che tua madre è stata aggredita con quell’acido, aveva sempre paura che se tu fossi tornata qua ti sarebbe successo qualcosa…”
Vedevo la paura nei suoi occhi.
“Volevano che morisse, che non lavorasse più, che non dipingesse…. Volevano rovinarle gli occhi. Miravano agli occhi… Volevano prendere il suo studio.”
Parlava senza fermarsi e farmi dire almeno una parola: della mafia locale e delle privatizzazioni selvagge, di quasi tutti i quadri di mia madre semplicemente regalati alla città.
E non solo i quadri. I libri, i disegni, e poi, il mio pianoforte, i miei libri e i miei quadri, i miei vestiti, i nostri ricordi, i soldi che mandavo incastrati fra i fogli delle lettere e come lei aveva regalato tutto o quasi ad altri. E alla fine toccava delicatamente la questione della nostra casa, la mia casa regalata in anticipo ad Antonina in segno di affetto e di ringraziamento.
La sera prima della mia partenza ricordai che un giorno mia madre mi aveva parlato di soldi avvolti in un straccio nello sgabuzzino in mezzo alle marmellate. Antonina mi guardò con sgomento: “Strano… non avevamo segreti…” Ma era visibilmente irritata. Cercammo per ore. Alla fine, verso due di notte, trovammo… lo straccio con i 100 dollari e una piccola lettera con la richiesta di dividere questi soldi fra me e Antonina. Non li volli.
Il giorno dopo, alla fermata del pulmino che doveva portarmi all’aeroporto di Kiev, sembravo quasi felice del mio ritorno a casa mia. In Italia. Ma penso che eravamo felici tutti e due. Ognuna per i propri motivi. Ci baciavamo. Ridevamo. O quasi.
Non so quando ho ceduto.
I pacchi con le foto erano così pesanti che dovevo cambiare mano ogni minuto: all’aeroporto di Borispol, in aereo, dopo l’atterraggio, fino alla macchina nel parcheggio coperto. Erano le foto della nostra vita piene di odore della mia infanzia mescolata alla trementina e ai colori ad olio, alla polvere costante a casa di mia madre per la voglia di non perdere tempo con il lavoro futile delle pulizie. E un pacco di pennelli di martora, una quarantina in tutto. Lavati e messi da parte con cura. Legati con un elastico. Era tutta la mia eredità.
Una sera, selezionando le foto per misura e per anni, quell’odore mi perforò le narici. Quella lontananza per le incomprensioni reciproche che per anni mi sembrava giusta, perse il suo significato in un istante. La sensazione di essere completamente sola nel mondo mi squarciava la gola e urlai con un urlo quasi disumano, come può urlare solo un animale ferito.
E sentivo correre su per le scale mio marito, gridando con una rabbia non camuffata: “Basta!!! Sei impazzita?!”
Non ancora, mi frullava nella testa. Perché riuscivo a capire la forza esagerata di quell’urlo buttando la faccia dentro il cuscino per tapparmi la bocca. Ma non ce la facevo più a fermarmi. Gridavo come prima. Gridavo Mammina mia!!!! … fino ad ululare. Che mi sentisse. Amami almeno adesso, come una madre può amare sua figlia, credimi almeno adesso!!!!! Aiutami adesso!!!! Dall’aldilà!!! Se puoi!!!! Amami!!!!!
Intanto mio marito tornando con tutta calma giù, sul divano, riceveva la seconda o terza telefonata giornaliera di sua madre. E raccontando a lei la mia inspiegabile pazzia, cercava di non farsi capire da me: parlava in friulano spiegando che quella li, sopra, dà i numeri…
E, allora, ho ceduto.